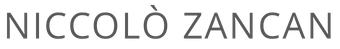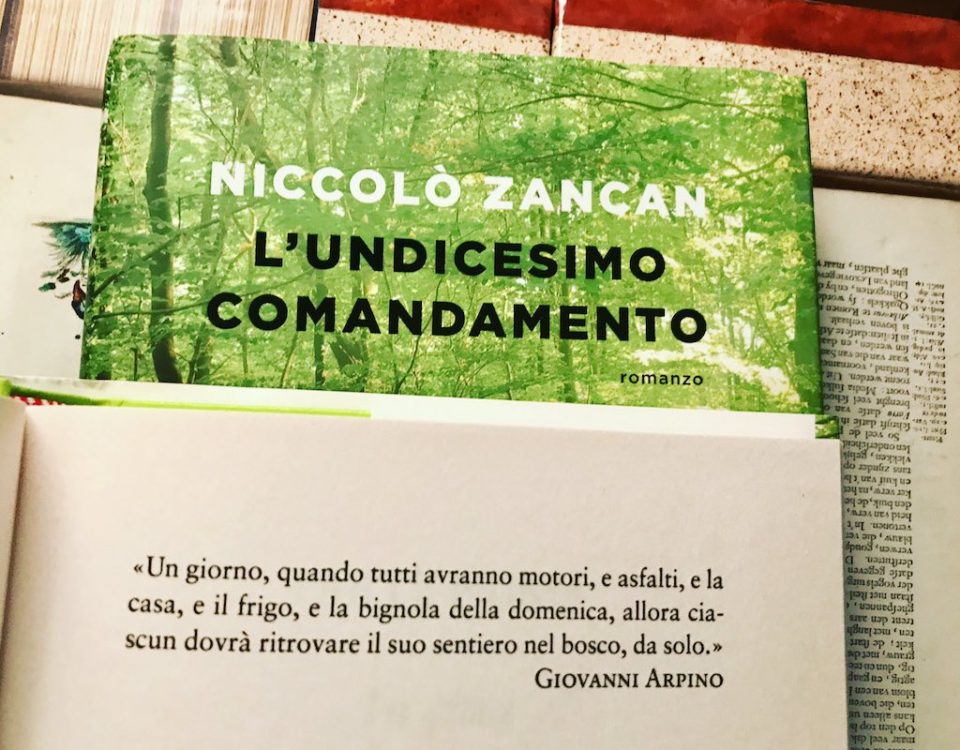L’undicesimo comandamento:
ecco perché l’ho scritto.
È successo in uno di quei vecchi bar di Riviera, con ancora il giornale steso sul frigo marrone dei gelati. Stavo bevendo un caffè lungo, mentre leggevo le pagine di cronaca locale, quando mi sono ritrovato a cercare di allargare una foto di carta con le dita. Era la foto di una ragazza arrestata per rapina a Santa Margherita Ligure, volevo ingrandirla per guardarla meglio, perché non era facile capire se stesse ridendo o fosse molto spaventata. E mi sembrò strano, anzi ingiusto, non poterla guardare dritta negli occhi come sul telefonino. Mi sembrò un errore della realtà.
Pochi giorni più tardi, ormai me ne ero quasi dimenticato, un titolo del telegiornale diceva: «Se vi ammalate di cancro, è colpa vostra». Pensavo a un mio amico morto a 39 anni per un tumore ai polmoni, la persona più forte che abbia incontrato nella vita. Un uomo impeccabile. Ne sono sicuro ancora adesso. Nonostante la teoria della meritocrazia salutista stia facendo proseliti.
Infatti, ne sono vittima anche io.
Nei viaggi che ho la fortuna di fare grazie al mio lavoro bellissimo, mi capita spesso di tornare negli stessi posti e rivedere le persone a distanza di tempo. E tutti, ogni volta, ci perdiamo nel solito balletto che sembra un sirtaki: avanti e indietro, in circolo, a braccetto. «Eh, sono un po’ ingrassato. Lo stress». «E sì, ora la barba è più bianca». «E tu, come fai, ti tingi i capelli?». Che stupido sirtaki! Le giustificazioni per quello che non possiamo essere. La rimozione della morte, l’ansia da efficenza fisica, il dovere di essere performanti – parola orribile – e questa paranoia da connessione perenne, che ci insegue anche davanti al mare. Sono questi pensieri, tutti insieme, ad aver suscitato in me prima un moto di rabbia e poi voglia di scrivere una storia, quasi per vendetta. Ne sono consapevole: non è un sentimento nobile. Ma depurata dall’odio, la vendetta può trasformarsi in rivolta. Quindi in gioia, libertà. Sì: avrei scritto la storia di un uomo stanco di essere bravo. Avrei scritto la storia di un uomo in cerca di un riscatto che, forse, nessuno capisce.
A lungo, nella mia testa, questo romanzo si è chiamato «Il Premio». Come quelli che senti promettere sotto gli ombrelloni durante le giornate d’estate eterna, quando sembra impossibile trovare requie e le madri venderebbero l’anima al diavolo per cinque minuti in pace: «Se sei bravo, zucchero mio, se stai zitto, la mamma ti dà un premio». Il premio per il migliore. Per il più bello. Per il più zitto. Se sei bravo. Se fai soldi. Sei hai tanti like. Se non invecchi. Se non ti ammali o perlomeno sei capace di guarire.
Mi serviva un protagonista che potesse ribellarsi a questa dittatura. Un po’ stronzo, ma anche un po’ simpatico. Doppio e confuso, fragile ma «performante». A lungo ho pensato a un manager e alle sue camice cifrate, ai movimenti millimetrici con cui muoveva forchetta e coltello durante le colazioni di lavoro, alla sua eleganza da squalo. Ma poi mi sono sentito vigliacco, come se stessi prendendo le distanze dalla storia che avevo nel cuore. E ho pensato che forse c’era una simmetria fra questo protagonista imploso e il giornalismo della carta stampata. Un modo così a repentaglio, adesso. Così in discussione, da lottare per la sua stessa sopravvivenza. Per questo motivo il mio protagonista, Andrea Marai, è diventato un reporter. Un bravo e fortunato reporter che, proprio nel giorno della sua consacrazione, perde il senso di quello che sta facendo. È stato premiato, ma non gli basta. Entra in crisi. Nessuno gli ha dato le istruzioni.